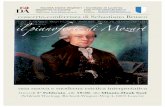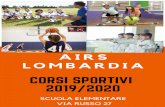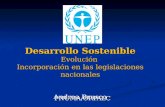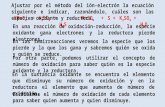Lafigurael’opera) di)...
Transcript of Lafigurael’opera) di)...
-
PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DELLA SARDEGNA
CAGLIARI
La figura e l’opera
di
Eusebio di Vercelli
Lavoro scritto in ordine al conseguimento
del Baccellierato in Sacra Teologia
RELATORE: Prof. A. Piras STUDENTE: Massimo Pibiri
A.A. 2012-‐‑2013
-
1
NOTA INTRODUTTIVA
Il lavoro di tesi che si vuole presentare è uno studio sul Padre della Chiesa
Eusebio, natione Sardus e vescovo di Vercelli, che ne faccia emergere la
personalità e la statura umana. L’ “ossatura” di tale lavoro coincide col tema
del convegno tenutosi a Cagliari nell’anno 1996 dal titolo “La Sardegna
paleocristiana tra Eusebio e Gregorio Magno”, a cui hanno contribuito autorevoli
studiosi.
La struttura della tesi comprende quattro ampi capitoli, ciascuno dei
quali costituisce una visione prospettica dell’oggetto di studio: Eusebio.
La trattazione non ha la pretesa di essere esaustiva, anche per il
carattere lacunoso della documentazione al riguardo, ma vuole essere un
ulteriore dovuto tributo alla testimonianza di fede di questo “nostro” Padre
della Chiesa.
-
2
CAP. 1
Il secolo di Eusebio
1.1 Inquadramento storico-‐‑religioso della vita del vescovo di Vercelli
Il fenomeno storico che fa da sfondo alla vita di Eusebio è il rapido
capovolgimento dei rapporti tra Chiesa e Impero: progressiva affermazione
della religione cristiana sul paganesimo, che costituisce la tendenza storica
dominante del IV secolo e dalla quale si stacca la politica anticristiana
dell’imperatore Giuliano (361-‐‑363), rappresentante la reazione pagana
insinuantesi nel IV secolo1.
In generale, la politica imperiale sembra orientata alla pacifica
accettazione del cristianesimo nella compagine dell’Impero -‐‑ ci si riferisce al
filocristianesimo dei Severi (193-‐‑235) -‐‑, nonostante la situazione dei rapporti
tra Chiesa e Impero appaia nel suo insieme mutevole: alternanza di lunghi
periodi di tolleranza con episodi di persecuzione di differente gravità2.
Tra la fine del II secolo e i primi decenni del III le istituzioni
ecclesiastiche si affermano progressivamente in un Impero ufficialmente
persecutore e l’adesione degli ambienti di corte e delle famiglie senatorie al
cristianesimo prefigura il definitivo atto di conquista dell’Impero da parte
della Chiesa. Sono da registrare, nel medesimo contesto, alcuni casi singolari
di collaborazione tra la familia principis e cristiani ben conosciuti a Roma (si
consideri, fra tutti, quello del poligrafo Giulio Africano)3.
Intorno alla metà del III secolo, al lungo periodo di pace e ai molteplici
1 Riguardo ai fondamenti del potere dell'Imperatore sulla Chiesa si veda R. FARINA, L'ʹimpero e l'ʹimperatore cristiano in Eusebio di Cesarea. La prima teologia politica del Cristianesimo, Zürich 1996, 237-‐‑239. 2 Cfr M. SORDI, I cristiani e l'ʹimpero romano, Milano 1991, 105-‐‑110. 3 Cfr E. DAL COVOLO, I Severi e il cristianesimo. Ricerche sull'ʹambiente storico-‐‑istituzionale delle origini cristiane tra il secondo e il terzo secolo, Roma 1989, 74-‐‑75.
-
3
episodi di dialogo tra Chiesa e Impero4 pone termine in modo brusco la
persecuzione di Decio, che insieme alle successive persecuzioni per editto,
quella di Valeriano del 257 e di Diocleziano del 303, rinvia di qualche
decennio la soluzione del conflitto fra le due istituzioni.
Lattanzio ed Eusebio di Cesarea sono le due fonti che conservano
l’editto promulgato a Nicomedia da Diocleziano il 24 Febbraio del 303 e che
prevedeva, secondo Lattanzio, la privazione ai cristiani di tutti gli onori e le
dignità, che questi fossero passibili di supplizio, a qualunque ordine e grado
appartenessero, e che non potessero ricorrere in giudizio in caso di azione
legale intentata contro di loro5. Secondo Eusebio di Cesarea, era previsto
nello stesso editto che le chiese e le Scritture fossero distrutte, che i cristiani
perdessero ogni dignità, che a servitori e liberti cristiani rimasti fedeli alla
loro religione fosse tolta la libertà. Si aggiunsero, poco tempo dopo, altri due
decreti di persecuzione che ordinavano di imprigionare in ogni luogo i capi
delle chiese e di costringerli con tutti i mezzi a sacrificare. Questi, a loro
volta, furono seguiti da un altro editto che prevedeva la libertà per chi avesse
sacrificato e il tormento dei supplizi per chi avesse resistito6. La maggior
parte della critica crede che Eusebio si riferisca a quattro editti di
persecuzione, promulgati dall’imperatore in pochi mesi, uno dopo l’altro. In
ogni caso, la politica religiosa di Diocleziano corrispondeva esattamente alla
sua concezione della tetrarchia, secondo cui dalla teocrazia tetrarchica
dipendeva la concordia imperatorum che, a sua volta, garantiva la concordia
militum e la coesione dell’Impero.
La teologia imperiale inaspriva, così, la tendenza ad una radicalità
crescente nel campo della politica religiosa. Successivamente alla rinuncia al
trono da parte di Diocleziano, che avvenne il 1 maggio del 305, la
4 Cfr ID., Chiesa Società Politica. Aree di «laicità» nel cristianesimo delle origini, Roma 1994, 123-‐‑127. 5 Cfr. LATTANZIO, La morte dei persecutori, a cura di G. Mazzoni, Siena 1930, 16-‐‑21. 6 Cfr. EUSEBIO, Storia Ecclesiastica, introduzione a cura di F. Migliore, Roma 2001, 150-‐‑157.
-
4
persecuzione diminuisce di intensità e il 30 aprile del 311 l’imperatore
Galerio pubblica l’editto di indulgentia verso i cristiani, il cui testo, sempre
conservato dalle due fonti precedentemente citate, contiene gli elementi del
contrasto tra cristianesimo e Roma e la giustificazione del nuovo
atteggiamento dell’Impero verso la Chiesa. Innanzitutto, Galerio riprende i
grandi temi della politica di Roma verso i cristiani, oltre a quelli
dell’ideologia tetrarchica7. Inoltre, la sostanziale responsabilità di Galerio
nella politica di Diocleziano sembra essere dimostrata dalla ricostruzione dei
fatti basata sull’editto, che legittima il cambio di una linea politica
fallimentare.
La “chiave di volta” di questo sviluppo è costituita da una nuova
considerazione del deus Christianorum, secondo la quale egli ha un posto di
rilievo nella visione espressa dall’editto: attraverso le preghiere dei cristiani,
gli viene affidata la salvezza degli imperatori e della stessa res publica. La
persistenza dell’ideologia religiosa imperiale è rivelata da numerosi indizi e
si accompagna, nel caso specifico del nostro editto, ad una scelta
terminologica che denuncia il programma galeriano. Insieme alla percezione,
da parte di Galerio e degli altri imperatori, della necessità di ricomporre i
sentimenti tra i cittadini di una ormai fragile società, si inizia ad avvertire la
possibilità che il cristianesimo diventi, esauriti i poteri del vecchio
politeismo, l’anima e lo strumento di una riforma civile. È un elemento di
notevole rilievo il fatto che lo stesso politeismo abbia assunto un peso e un
significato del tutto diverso nel nuovo quadro.
L’editto, oltre ad essere sintomo di una situazione gravida di novità
impreviste, costituisce un punto di passaggio verso le litterae di Costantino e
Licinio del 313. La presunta conversione di Costantino del 312 e il cosiddetto
editto di Milano del 313 segnano la vera svolta nei rapporti tra la Chiesa e
l’Impero; a un tratto, all’inizio del IV secolo, la Chiesa acquista completa 7 Cfr. G. JOSSA, I cristiani e l'ʹimpero romano da Tiberio a Marco Aurelio, Napoli 1991, 229 ss.
-
5
libertà, fino a godere privilegi sempre più ampi. Il nome dell’imperatore
Costantino è legato in modo indiscutibile a questa rivoluzione: eliminato
Licinio, l’imperatore diventava l’unico Augusto. Si realizzava, così, sulla
terra l’unità assoluta di governo, la monarchía dell’oikouméne, che nel terzo
secolo aveva assunto un'ʹimportanza, anche ideologica, preminente.
Il quarto secolo dava realtà concreta alla parola monarchía: Massenzio e
Costantino avevano il titolo di totius orbis imperator. Nel 324, sconfitto Licinio,
Costantino ha attuato la politica universale e nel 325, al concilio di Nicea da
lui convocato, ha partecipato alla definizione del concetto cattolico di
monarchía divina nel quadro del dogma trinitario8. Costantino favorì in tutti i
modi l’episcopato ed intervenne attivamente nelle dispute teologiche che
laceravano la comunità cristiana, segnatamente nella controversia ariana e
nella crisi donatista. La sua politica religiosa appare per lo più ispirata alla
ricerca di formule conciliative e dà contenuto alla formula di epíscopos tôn
ektós o a quella di koinòs epíscopos, che definiscono in modo emblematico il
compito di supremo moderatore della religio cristiana assunto
dall’imperatore nell’interesse dell’impero, nel senso di porre sotto tutela di
una sola religio tutto l’orbe romano. Costantino ha compiuto le sue scelte
religiose nella prospettiva in cui l’Augusto era riconosciuto il mediatore tra il
divino e l’umano9. In realtà, prevale sempre nella sua politica religiosa
l’intento di imporre concordia e unità, a costo di conciliare istanze fra loro
contrastanti.
Mentre Costantino, in linea di principio, si sforzò di garantire la
coesistenza del culto pagano con quello cristiano, la legislazione imperiale fu,
invece, irrigidita dai suoi successori, fino all’abolizione del culto degli dei10.
L’imperatore Giuliano, detto l’Apostata, si fece paladino della reazione pagana
8 Cfr. S. MAZZARINO, L'ʹimpero romano, III, Roma-‐‑Bari 1973, 658-‐‑659. 9 Cfr. G. BONAMENTE, La «svolta costantiniana», in E. DAL COVOLO – R. UGLIONE (edd.), Cristianesimo e istituzioni politiche, Roma 1995, 102. 10 P.F. BEATRICE, L'ʹintolleranza cristiana nei confronti dei pagani, Bologna 1993, 7-‐‑13.
-
6
che serpeggiava negli ambienti culturali del IV secolo. Tra il 361 e il 363 egli
impostò una rigida politica di restaurazione del paganesimo. Il suo
provvedimento anticristiano più famoso mirava a togliere l’insegnamento ai
professori cristiani11. Si noti che, benché si debba riconoscere un progressivo
irrigidimento della politica religiosa imperiale, in stretto rapporto con la
reazione pagana del IV secolo, il caso di Giuliano resta, tuttavia, un caso
isolato.
L’imperatore Teodosio pubblica a Tessalonica l’editto Cunctos populos,
con il quale prescrive a tutti i sudditi dell’Impero la religione cristiana. In
realtà l’editto di Tessalonica e i provvedimenti immediatamente successivi
riprendono la politica antipagana di Costanzo e obbediscono alla logica che
la repressione religiosa ha sempre assunto nella tradizione romana, durante
l’Impero cristiano e, soprattutto, durante l’Impero pagano e la Repubblica: il
culto da reprimere è assimilato al sacrilegio, all’empietà, alla magia o
all’ateismo. La repressione, dunque, si proclama diretta contro una
perversione della religione, contro una profanazione colpevole e pericolosa
per la res publica12.
La politica religiosa dell’Impero ha sempre inteso garantire la
protezione della divinità per la propria salvezza, presentando ad essa la
sottomissione di un culto senza impedimenti. Gli interventi legislativi da
Galerio a Teodosio si trovano paradossalmente sulla linea della tradizione
romana, una volta decisa, dopo Galerio, l’inopportunità della persecuzione
contro i cristiani. Poiché occorreva sostituire il culto pagano con il culto
cristiano, lasciando intatto il sistema del raccordo tra politica e religione,
unica garanzia di sopravvivenza per l’Impero, il cristianesimo diviene la
religione ufficiale di Roma.
11 Cfr. E. DAL COVOLO, La paideia anticristiana dell'ʹimperatore Giuliano. A proposito dell'ʹeditto del 17 giugno 362, in Crescita dell'ʹuomo nellacatechesi dei Padri, Roma 1988, 73-‐‑85. 12 M. SORDI, L'ʹatteggiamento di Ambrogio di fronte a Roma e al paganesimo, in Ambrosius Episcopus. Atti del Congresso internazionale di studi ambrosiani, Milano 1976, 203 ss.
-
7
Oltre alle evidenti ambiguità del processo di sostituzione e la pesante
ingerenza dell’imperatore nelle vicende della Chiesa, bisogna considerare
anche le enormi possibilità che venivano aperte alle comunità cristiane. In
ogni caso non si deve pensare all’editto di Teodosio come a un rivolgimento
improvviso13. La vita del vescovo di Vercelli si inquadra, dal punto di vista
storico-‐‑religioso, in questo complesso fenomeno della sostituzione del culto
pagano14.
1.2 Il pensiero politico dell’età eusebiana
Certamente il Cristianesimo ha subito immediatamente dei riflessi politici.
Fin dai primi documenti cristiani emergono affermazioni di indubbio
carattere politico. Si rilevano la non immediata politicità del movimento e
dei suoi testi fondamentali, cui consegue la fluidità del rapporto fra
cristianesimo e politica, e la mancanza di trattazioni politiche organiche
ampie e diffuse.
Nel IV secolo questo magma porta in primo piano alcuni problemi
politici di grande momento. Alcuni motivi della riflessione politica discussi
nel secolo di Eusebio sono destinati a grandi sviluppi nei secoli venturi fino
al medioevo. In particolare, in questo secolo iniziano ad affiorare i motivi
essenziali della futura dottrina della teocrazia papale che troveranno pieno
sviluppo molti secoli dopo. Innanzitutto, questa elaborazione politica si
muove in un ambiente ancora romano ed è opera di uomini romani ancora
fortemente legati alla tradizione, al pensiero, alla cultura, alla mentalità
romani. Inoltre, il ragionare politico del IV secolo è complicato dal fatto che
alcune affermazioni fondamentali sono quanto mai ambigue nella realtà dei
fatti e della prassi politica. Ambiguità nella prassi che non può che creare e
13Cfr. E. CROVELLA, La chiesa Eusebiana: dalle origini alla fine del secolo VIII, Vercelli 1968. 14 Cfr. E. DAL COVOLO, Il “capovolgimento” dei rapporti tra la Chiesa e l’Impero nel secolo di Eusebio di Vercelli, in La Sardegna paleocristiana tra Eusebio e Gregorio Magno, Atti del Convegno Nazionale di Studi, a cura di A. Mastino -‐‑ G. Sotgiu -‐‑ N. Spaccapelo, Cagliari 1999 137-‐‑152.
-
8
produrre infinite e gravissime incertezze, spesso risolvibili soltanto sul piano
della forza o della scelta personale15.
Fra II e III secolo nella letteratura cristiana sembrano prevalere
nettamente le posizioni concilianti nei confronti dell’Impero. Anzi, molto
spesso viene riconosciuta all’Impero Romano una funzione positiva e
indispensabile nell’economia dello sviluppo della stessa società cristiana.
L’essenza di questa prima dottrina politica cristiana è rappresentata dal fatto
che la politica esiste soltanto in funzione della religione cristiana; al di fuori
del cristianesimo potrebbe essere soltanto un fatto privo di valore. Si intuisce
che la politica non è una costante della vita umana. Ci si inizia ad allontanare
dalla concezione classica, secondo la quale la politica, la vita sociale e politica
sono intimamente umane, sono intrinseche alla natura dell’uomo.
Il contrasto fra Ambrogio di Milano e gli imperatori Valentiniano II e
Teodosio è un fatto ben noto del IV secolo. Relativamente agli avvenimenti
cruciali in cui il contrasto si mostra in tutta la sua drammaticità, Ambrogio ci
offre autenticamente il suo pensiero in alcune lettere. Al principio del 385 le
autorità civili di Milano chiedono al vescovo Ambrogio di cedere una
basilica agli eretici ariani, affinché anche costoro possano celebrare la
Pasqua. Nella controversia che ne consegue e che dura circa un anno,
Ambrogio si oppone e, con l’aiuto dalla popolazione, ha la meglio. Tre anni
dopo a Callinico i cristiani istigati dal vescovo hanno bruciato la sinagoga e,
contemporaneamente, un gruppo di monaci ha distrutto il luogo di riunione
degli eretici valentiniani. L’imperatore Teodosio ordina che la sinagoga sia
ricostruita a spese del vescovo e che sia iniziato il procedimento giudiziario
contro i monaci. Anche questa volta Ambrogio la spunta: né risarcimento né
processo. Nel 390 a Tessalonica la folla imbestialita massacra il magister
15 Cfr. A. PETRUSI, La concezione politica e sociale dell'ʹImpero di Giustiniano, in Storia delle idee politiche e sociali, diretta da L. Firpo, II: Ebraismo e cristianesimo. Il Medioevo, tomo I, Torino 1985, 540 ss.
-
9
militum Butheric per aver arrestato un fantino delle corse del circo. Teodosio
reagisce duramente, perché la violenza della folla rischia di mettere in crisi i
patti e gli accordi fra l’Impero e i contingenti barbarici, che avevano accettato
di servire Roma. Ambrogio chiede all’imperatore di fare penitenza pubblica
e la spunta per la terza volta: Teodosio entra in chiesa da penitente e
Ambrogio lo riammette nella comunità dei fedeli.
Esaminando questi tre episodi di scontro, ricordiamo che, secondo
quanto asserisce Carl Schmitt in materia di sovranità nel suo fondamentale
saggio Teologia politica del 1922, è sovrano colui che decide dello stato di
eccezione. Questa definizione è appropriata al concetto di sovranità come
concetto limite, relativo alla sfera più interna. A ciò corrisponde il fatto che la
sua definizione può applicarsi ad un caso limite. Stato d’eccezione va inteso
come un concetto generale della dottrina dello Stato. Il fatto ha una ragione
sistematica, di logica giuridica. Infatti, la decisione intorno alla eccezione è
decisione in senso eminente. La prova dell’esistenza di uno stato di
emergenza non può essere giuridica. Qui sta il problema. In generale è
un’espressione del liberalismo dello Stato di diritto e disconosce il significato
autonomo della decisione. Il caso d’eccezione può al massimo essere indicato
come caso di emergenza esterna, non con riferimento alla situazione di fatto.
Solo questo caso rende attuale la questione relativa al soggetto della
sovranità. Non si può affermare con chiarezza incontrovertibile quando
sussista un caso d’emergenza, né si può descrivere dal punto di vista del
contenuto che cosa possa accadere quando realmente si tratta del caso
estremo di emergenza e del suo superamento. Il presupposto e il contenuto
della competenza sono qui necessariamente illimitati. Anzi, dal punto di
vista dello Stato di diritto non sussiste qui nessuna competenza. La
costituzione può al più indicare chi deve agire in un siffatto caso. Se
quest’azione non è sottoposta a nessun controllo, il sovrano è colui che
decide sul fatto se sussista il caso estremo di emergenza e sul fatto di che
-
10
cosa si debba fare per superarlo. Egli sta al di fuori dell’ordinamento
giuridico normalmente vigente e, tuttavia, appartiene ad esso poiché a lui
tocca la competenza di decidere se la costituzione in toto possa essere
sospesa. Tutte le tendenze del moderno sviluppo dello Stato di diritto
concorrono ad escludere un sovrano in questo senso16.
In tutti e tre i casi Ambrogio decide in modo autonomo, mediante una
sua esclusiva manifestazione di volontà, che è il momento di intervenire nel
dominio del temporale. Nel primo episodio è Ambrogio stesso a decidere
della legittimità del proprio intervento. L’intervento avviene per decisione
dello stesso Ambrogio, giudice della legittimità del suo proprio agire.
Ambrogio afferma ripetutamente che tutto ciò che riguarda la chiesa deve
essere deciso dai vescovi e che l’oggetto del contendere è questione di chiesa.
Ambrogio nel suo discorso contro Aussenzio e contro la cessione della
basilica agli ariani non dà alcuna motivazione della sua dichiarazione,
cosicché l’ambito di applicazione del principio resta indeterminato fino a
quando non viene delimitato e individuato dalla volontà discrezionale dello
stesso Ambrogio. Analogo è il caso della sinagoga di Callinico, nel quale è
più evidente la competenza giuridica dell’autorità civile. Eppure, nelle sue
dichiarazioni non si trova mai una precisazione sul perché queste siano
faccende di sua competenza e penitenza. Nel terzo episodio, il più
significativo, Ambrogio si pretende arbitro insindacabile del decidere che le
regole normali del potere imperiale sono sospese, perché l’imperatore ha
travalicato nel campo morale. L’intervento di Ambrogio opera ed ha effetti
nel campo della legittimità del governante. Il suo agire è attentamente
coerente ed organico nel conseguimento di un fine ben chiaro e prestabilito:
la libertà per la chiesa che diventa subito il predominio della Chiesa17. Si
16
Cfr. C. SCHMITT, Teologia politica Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, traduzione in Le categorie del 'ʹpolitico'ʹ, a cura di G. Miglio e P. Schiera, Bologna 1972, 20 ss. 17 Cfr. S. MAZZARINO, Storia sociale del vescovo Ambrogio, Roma 1989, 10.
-
11
riscontra nell’agire e nel pensare di Ambrogio l’idea che il potere spirituale
ha una dignità e una forza intrinsecamente superiori a quella di ogni
possibile potere temporale. La legge terrena è così ridotta a mera costrizione.
A giustificare e spiegare l’agire di Ambrogio sta l’idea che la politica sia
necessaria soltanto perché nel mondo esiste il male. Ma, affinché il male della
forza sia accettabile, occorre che la forza sia usata sotto la guida del
sacerdote, di colui che meglio dei governanti temporali sa che cosa è bene
per la comunità dei credenti. Il giudizio finale sullo stato d’eccezione
appartiene al sacerdote, perché egli è in possesso di un potere che è più alto
in quanto derivante dal bene. Ambrogio può decidere quali atti di Teodosio
rientrino sotto la sua giurisdizione ecclesiastica18. Sulla base di quanto detto,
risulta che il vero sovrano è il sacerdote, più tardi sarà il pontefice, nel quale,
almeno in Occidente, tutta la chiesa è riassunta. Diversa sarà la situazione
orientale e, ancor più, quella tardo-‐‑medioevale con l’emergere degli Stati.
Ambrogio impedisce a Teodosio di svolgere le sue funzioni di imperatore,
mette in dubbio la sua capacità di esercitare funzioni pubbliche in quel
momento in cui è un peccatore che non ha ancora espiato. Lo considera
sospeso19. Essere in grazia di Dio è la condizione che deve essere valida e
dimostrata in ogni istante della vita del governante e dell’esercizio del suo
potere. Appare chiaramente che il sacerdote pretende di intervenire nel
temporale a causa del peccato commesso dal governante. Ma unico giudice
di questa condizione di grazia è il sacerdote, che è allo stesso tempo parte in
causa e giudice superiore. Ambrogio nega a Teodosio la qualità di cristiano
in grazia e gli impedisce di partecipare a quei sacri riti, che sono poi parte
essenziale e irrinunciabile del suo stesso essere imperatore e del suo svolgere
le funzioni di imperatore.
18 Riguardo ai Donatisti si veda la posizione di OTTATO DI MILEVI, Traitè contre les Donatistes, Parigi 1985. 19
Cfr. AMBROGIO DI MILANO, De obitu Theodosii, 33, in Orationes funebres, a cura di G. Banterle, Milano-‐‑Roma 1985, 234-‐‑235.
-
12
Inizia qui l’uso politico della scomunica o, quanto meno, con forti
conseguenze politiche. Per essere veramente certi della legittimità e
correttezza del proprio agire i governanti devono procedere secondo le
indicazioni del sacerdote. Un altro passo verso la teocrazia è stato compiuto.
Evidentemente la situazione di fatto e i diversi rapporti di forza hanno svolto
un gran ruolo e gli sviluppi maggiori del pensiero del quale si è parlato
verranno quando Roma sarà lontana nel tempo e dimenticata come
tradizione politica20.
20 Cfr. C. FINZI, Il pensiero politico dell’età eusebiana, in La Sardegna paleocristiana cit., 153-‐‑167.
-
13
CAP. 2 Eusebio vescovo, confessore, monaco
2.1 Impegno pastorale e aspetto testimoniale
Girolamo descrive nel 393 la vita di 132 “uomini illustri” del cristianesimo,
tra i quali figurano Eusebio di Vercelli e Lucifero di Cagliari.
Eusebio di Vercelli balza agli onori della storia nell’anno 345.
Riguardo alla sua vita e alla sua attività pastorale prima dell’episcopato,
sappiamo che era nato in Sardegna e a Roma era stato ordinato “lettore”
nella Chiesa. Si immagina la sua nascita tra la fine del III e l’inizio del IV
secolo. Eusebio doveva essere giovanissimo quando la sua famiglia lasciò la
Sardegna. Ambrogio, in una lettera del 396, dice di lui che alla tranquillità
della sua casa preferiva le peregrinazioni21. La sua terra d’origine aveva
accolto l’annunzio del Vangelo dalla voce e dalla testimonianza degli esuli,
dei mercanti, dei soldati, dei presbiteri e dei martiri. Lo schiavo Callisto,
esule in Sardegna, liberato attorno all’anno 190 per l’amnistia dell’imperatore
Commodo, fu vescovo di Roma dal 217 al 222. Della morte di Papa Ponziano
nel 235 durante l’esilio nell’Isola dà notizia il “Catalogo Liberiano” redatto a
Roma nel 354, mentre Eusebio era vescovo di Vercelli. Eusebio avrà sentito
parlare dei martiri sardi del suo tempo, morti sotto la tremenda persecuzione
di Diocleziano, che intendeva salvare l’Impero con una ferrea organizzazione
politica e per questo esigeva dai cristiani l’assenso religioso agli dei di Roma.
Con la tetrarchia la città di Sirmio diveniva il cuore del nuovo impero. Gli
editti di Diocleziano degli anni 303-‐‑304 intendevano radere al suolo le chiese
cristiane. Le stragi furono innumerevoli. Diocleziano, dopo aver chiamato
Costantino a Sirmio, si ritirò nel 305, aprendo il periodo delle lotte fra i vari 21 AMBROGIO, Epist. ex. coll. 14, 68.
-
14
capi imperiali. La contesa si concluse con la vittoria di Costantino, il quale
nel 313 confermò l’editto di tolleranza di Galerio donando la pace religiosa ai
cristiani. In quel momento era vescovo di Roma Melchiade.
Forse giunse in quegli anni Eusebio, o poco più tardi, quando era papa
il romano Silvestro. L’imperatore Costantino metteva a disposizione del papa
il palazzo dei Laterani e iniziava l’edificazione della basilica di San Giovanni.
Eusebio, entrato nell’ambiente ecclesiale, si dedicò al servizio ministeriale
nella comunità. La missione di “lettore” era di grande importanza nella
Chiesa di quel tempo e preludeva spesso al sacerdozio22.
Il primo agosto del 314 Quintasio vescovo di Cagliari e il suo
presbitero Ammonio partecipavano al concilio di Arles23. A Cesarea di
Palestina era intanto divenuto vescovo Eusebio, il quale considerava una
provvidenziale grazia la libertà religiosa, che più tardi invece Eusebio di
Vercelli avrebbe pagato con la persecuzione da parte del figlio di Costantino.
Il IV secolo ben presto avrebbe visto il riaccendersi delle roventi
controversie dottrinali, le quali seminarono dolorose divisioni e risvegliarono
nuove persecuzioni. Il prete libico Ario si poneva alla testa nella Chiesa di
Alessandria del movimento dottrinale che conduceva a negare la divinità di
Gesù24. Il suo vescovo Alessandro convocò Ario ad un sinodo attorno al 320
ad Alessandria e lo condannò. Eusebio di Cesarea accolse Ario nella sua
diocesi, favorendo così la diffusione delle controversie teologiche. Nel
maggio del 325 Costantino chiamò tutti i vescovi al concilio di Nicea25. La
“formula di fede” proposta dal concilio si incentrava sull’affermazione che il
Figlio è “consustanziale al Padre”; essa fu sottoscritta a malincuore da molti
vescovi e divenne la pietra d’inciampo.
22 Cfr. T. BOSCO, Eusebio di Vercelli nel suo tempo pagano e cristiano, Torino 1995, 32-‐‑35. 23 Cfr. O. ALBERTI, La Sardegna nella storia dei Concili, Roma 1964, 3-‐‑7. 24
Per ulteriori approfondimenti sull'Arianesimo si veda M. SIMONETTI, La crisi ariana nel IV secolo, Roma 1975. 25 Cfr. P. MELONI, Laici e impegno nella società alle origini del cristianesimo, in Laici nella Chiesa e nella società, Roma 1987, 118-‐‑127.
-
15
Il dopo-‐‑Nicea fu la liquidazione dell’accordo teologico stabilito in quel
concilio. L’arianesimo ebbe il suo trionfo in Oriente e penetrò poi in
Occidente. L’atmosfera “teologica” andava profondamente trasformandosi.
Nel secolo del riconoscimento statale del cristianesimo il pensiero dei
cristiani confluì in un’eresia unica e totalizzante. Si trattava della divinità di
Gesù Cristo nella unità e trinità di Dio e, dopo quello che fu il primo concilio
ecumenico, anche della fedeltà alla verità proclamata dal collegio episcopale
e confermata dal vescovo di Roma. La libertà di riflessione teologica non era
più la stessa dei tre secoli precedenti, in quanto il “dogma” doveva essere
prima accolto per poter essere ulteriormente approfondito. L’unità tra le
Chiese, fondamentale per la testimonianza missionaria, doveva essere basata
sulla verità. Nel tempo della libertà religiosa rimaneva importante credere
che “Cristo è Dio” per andare incontro all’impegno della vita cristiana.
Questo era l’intendimento dei Padri. Era necessaria l’unità nella fede.
Eusebio a Roma ebbe la possibilità di comprendere il profondo
contenuto della dottrina trinitaria e anche di intuire le sottigliezze degli
argomenti teologici dell’Oriente. Lo preoccupava la progressiva
“arianizzazione” delle Chiese orientali, che rischiava di estendersi a quelle
occidentali. Nel 335, infatti, un concilio riunito a Tiro aveva deposto
Atanasio, vescovo di Alessandria. Costantino dava ormai man forte ai
vescovi ariani, nello stesso tempo in cui moriva papa Silvestro. Nel 335
moriva anche Ario. Il 7 febbraio del 337 veniva eletto papa Giulio e il 22
Maggio dello stesso anno morì a Nicomedia lo stesso Costantino. I suoi eredi
furono i figli Costantino jr., Costanzo II e Costante. Costantino aveva
sostenuto di fatto gli Ariani e aveva trasmesso ai propri figli la convinzione
che l’azione politica dovesse appoggiarsi preferibilmente sulla fazione
filoariana. Nel 339 il vescovo di Roma Giulio aveva dovuto accogliere nella
capitale Atanasio, espulso ancora dalla diocesi di Alessandria. La sua
presenza a Roma fu per Eusebio la provvidenziale occasione di penetrare
-
16
nelle profondità della dottrina trinitaria dell’Oriente. Nel 342, morto Eusebio
di Nicomedia vescovo di Costantinopoli, qualche sprazzo di riconciliazione
sembrò riaprire le porte al dialogo, quando Costante e Costanzo proposero
un nuovo Concilio a Serdica nel 343-‐‑344, dei cui atti riportiamo un brano
significativo:
Il vescovo Ossio disse: Anche questo necessario che venga aggiunto: che nessuno dei vescovi passi dalla sua provincia in un'ʹaltra provincia in cui già ci sono vescovi; eccetto forse che non sia stato chiamato dai suoi fratelli, perché non sembri che chiudiamo la porta alla carità. Egualmente da prevedere anche questo: che se in una provincia un qualche vescovo ha una pratica contro un suo fratello episcopo, nessuno dei due convochi come arbitri vescovi da un'ʹaltra provincia. Se poi però risulterà che uno dei vescovi in una pratica sia stato condannato ed è convinto di avere una pratica non debole, ma buona, cosicché il giudizio possa venire ancora rinnovato, se sembra bene alla vostra carità, onoriamo la memoria dell'ʹapostolo Pietro, e si scriva da coloro che hanno giudicato [a Giulio], il vescovo di Roma, così che da parte dei vescovi confinanti con quella provincia, se necessario, venga fatto un nuovo giudizio ed egli presenti gli arbitri. Se però non può venire dimostrato che la sua questione è tale da abbisognare una revisione, quanto antecedentemente giudicato non venga abolito, ma rimanga stabilito. Il vescovo Gaudenzio disse: Se sembra bene, necessario che a questa dichiarazione, che hai espresso piena di manifesta carità, venga aggiunto che se un vescovo, al giudizio di questi vescovi venisse deposto, dicesse che gli spetta ancora un procedimento di difesa, non venga messo sulla cattedra un altro, se , avendo deciso di questo, il vescovo della dei romani non abbia presentato una norma. Il vescovo Osio disse: Piacque che se un vescovo è stato accusato e i vescovi della medesima regione radunati lo rimuoveranno dal grado, e come deposto si rifugierà presso il beatissimo vescovo della chiesa dei Romani e voglia sapere di lui e pensi essere giusto che venga rinnovato l'ʹesame della sua pratica si degni di scrivere a quei vescovi che sono confinanti con quella provincia, affinché essi con cura e diligenza indaghino ogni cosa e secondo la credibilità della verità presentino una sentenza circa la pratica.
Se invece qualcuno ritiene opportuno che la sua faccenda venga anche riascoltata e con la sua richiesta giudicasse bene muovere il vescovo dei Romani a mandare dal suo lato dei presbiteri, è in potere dello stesso vescovo che cosa ritenga che sia bene e stabilisse che debbono essere mandati alcuni che giudichino insieme ai vescovi e che abbiano l'ʹautorità di colui dal quale sono stati mandati, anche questo da accogliere. Se invece reputa di iniziare dalla conoscenza
-
17
presente> della pratica e dalla sentenza sul vescovo, faccia quanto giudica che sia bene nella sua assennatissima deliberazione. I vescovi risposero: Piacque ciò che è stato esposto26.
Papa Giulio inviò i preti Archidamo e Filosseno ed il diacono Leone
come suoi legati, e da Treviri vi andò, con Atanasio, Osio di Cordova. La
riconciliazione fallì e il credo niceno fu definitivamente abbandonato dai
vescovi orientali. Anche l’incontro tenuto a Milano nel 345 ebbe un esito
negativo. Era penetrato in Occidente il germe dell’Arianesimo. La zona più
vulnerabile era l’Italia Settentrionale, confinante con la regione balcanica
impregnata del pensiero ariano orientale. Aquileia era, insieme a Verona e
Brescia, una delle poche diocesi oltre all’antica diocesi di Milano. Nel
Piemonte nessuna comunità era stata ancora costituita in diocesi. Papa Giulio
prospettò la necessità di costituire una nuova diocesi per l’evangelizzazione
del Nord. Fu scelta come sede Vercelli.
Nel 49 a.C. Vercellae aveva ottenuto la cittadinanza romana da Giulio
Cesare. La città era in una posizione strategica per la confluenza di
importanti strade. Il culto di Apollo stava cedendo il posto al culto di Cristo.
Costantino vi aveva fatto costruire una chiesa dedicata a Maria e la tomba del
martire vercellese Teonesto era divenuta un santuario27. Papa Giulio inviò a
Vercelli una delegazione della quale faceva parte anche Eusebio. La
tradizione delle comunità cristiane vedeva nell’acclamazione del vescovo da
parte del popolo la volontà divina. Eusebio fu eletto a prima vista dal popolo
e la sua consacrazione episcopale avvenne a Roma per le mani di papa
Giulio.
È risaputo da diverse fonti quanto grande fosse nel IV secolo
26 H. DENZINGER, Enchiridion Symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, a cura di P. Hünermann, Bologna 2001, cann. 133-‐‑135. 27 Notizie riguardo al culto dei martiri sono pubblicate in Eusebio di Vercelli e il suo tempo, Atti del Convegno Internazionale, a cura di E. dal Covolo -‐‑ R. Uglione -‐‑ G. M. Vian, Roma 1997, 257-‐‑321.
-
18
l’impegno dei cristiani nell’affrontare con la forza del Vangelo i problemi
dell’Italia e del mondo. Ai problemi sociali dell’Italia di 1660 anni fa si
aggiungevano la rivalsa delle etnie, l’egoismo dei ricchi possidenti, il
risorgere della magia e dell’astrologia, l’esuberanza conviviale durante le
feste, il tifo smodato negli stadi, le strane acconciature dei capelli, gli
orecchini agli orecchi dei maschi oltre che delle donne. L’arrivo del vescovo
nel Piemonte infuse coraggio alla moltitudine dei poveri. La lettera che
Eusebio invierà alla comunità di Vercelli dal suo esilio in Palestina offre un
quadro della vita di quella Chiesa. Da Ambrogio sappiamo che Eusebio fu un
“santo confessore”28. Maestro della Parola di Dio, cercava di penetrarne il
profondo significato spirituale traducendo in latino il Commento ai Salmi di
Eusebio di Cesarea, e adoperando il Salterio come preghiera comunitaria nei
primi esperimenti di vita cenobitica con i suoi presbiteri29. La passione di
Eusebio per i Salmi fa capire il suo progetto di fondare in Occidente la
grande esperienza di vita comunitaria30.
Dal 345 al 355, mentre Eusebio evangelizzava il Piemonte, stava per
avvenire una nuova svolta nella storia della Chiesa e dell’Impero. Nel
gennaio del 350 un golpe ordito da Magnenzio destituì a Lione l’imperatore
Costante, che fu ucciso in battaglia presso i Pirenei. Costanzo II, appresa la
notizia in Oriente, risalì il Danubio fino alla confluenza della Sava a Sirmio.
Lo scontro avvenne nel settembre del 351 attorno alla città di Mursa, al
confluire della Drava col Danubio. Magnenzio fu sconfitto31. Costanzo lo
inseguì ad Aquileia e a Lione, dove Magnenzio si uccise il 10 agosto 353.
Costanzo rimaneva così unico signore dell’impero. Rifondata l’unità politica
dello Stato si dedica a rinvigorire l’unità della Chiesa. A papa Giulio il 12
28 AMBROGIO, Epist. ex. coll. 14, 66 e 71. 29 Per avere un'ʹidea dell'ʹopera di Eusebio di Vercelli si veda ORIGENE, Omelie sui Salmi, a cura di E. Prinzivalli, Firenze 1991. 30 Cfr. M. CAPELLINO, S. Eusebio di Vercelli, Vercelli 1996. 31 Cfr. SIMONETTI, La crisi ariana cit., 212 ss.
-
19
Aprile del 352 era succeduto Liberio, che era stato a Roma “lettore” e poi
“diacono”. Liberio conosceva bene la situazione ecclesiale dell’Italia e la
situazione politica dell’Impero. L’imperatore Costanzo era convinto della
necessità di eliminare Atanasio. Liberio, che considerava una roccia per la
fede il Credo di Nicea e vedeva in Atanasio il suo più strenuo difensore,
inviò i vescovi della Campania Marcello e Vincenzo dall’imperatore, il quale
si tratteneva ad Arles, per chiedere la convocazione di un concilio ad
Aquileia. Costanzo convoca il concilio ad Arles, onde poterlo pilotare
personalmente attraverso Saturnino, vescovo di quella città. Il decreto di
condanna di Atanasio fu sottoscritto dalla maggioranza dei vescovi della
Gallia. Con un sotterfugio fu carpita la firma anche ai legati pontifici.
Costanzo riuscì a far condannare ed esiliare Atanasio. Riguardo alla
“professione di fede”, l’imperatore ritenne di convogliare tutti i vescovi verso
una “formula” talmente generica che potesse essere da tutti sottoscritta. Papa
Liberio scrisse a Costanzo per chiedere la convocazione di un nuovo Concilio
in una città raggiungibile da un maggior numero di vescovi. Inviò alla corte
di Milano lo stesso Lucifero, con Pancrazio e Ilario, e pensò di affiancare a lui
Eusebio di Vercelli.
Il Concilio fu convocato dall’imperatore a Milano. Dal suo
svolgimento emerge l’importanza decisiva che la presenza di Eusebio
significava agli occhi dei sostenitori di Atanasio, dei loro avversari e
dell’imperatore. Questo grande prestigio era legato alla sua persona. Egli era
stato lettore nella chiesa di Roma, dove ebbe modo di informarsi
adeguatamente sui temi dottrinali e politici che erano oggetto della
controversia. È ipotizzabile che qui Eusebio avesse acquisito tanta
competenza sull’argomento da presentarsi come uno dei pochissimi in grado
di orientarsi con sicurezza in un contenzioso di non facile approccio; e come
tale era conosciuto a Roma e altrove. Eusebio pensò di prendere tempo prima
di presentarsi al concilio a Milano.
-
20
I lavori del concilio prendevano l’avvio con un’attiva propaganda da
parte dei vescovi favorevoli all’Arianesimo, i quali forzarono i vescovi
occidentali a sottoscrivere la condanna di Atanasio. I filoariani scrissero a
Eusebio invitandolo ad unirsi alla condanna di Atanasio. L’ambasciata non
riuscì a smuovere il vescovo di Vercelli, tanto che l’imperatore gli inviò una
sua lettera personale. Eusebio annunziò il suo imminente intervento a
Milano. La notizia mise in agitazione i vescovi filoariani, tanto che
l’imperatore dovette assecondarli. Dieci giorni dopo, Eusebio venne accolto
nell’assemblea conciliare e fu invitato a sottoscrivere la condanna di
Atanasio. Egli manifestò ai padri conciliari la necessità di accertare
previamente l’ortodossia dottrinale di tutti i presenti e domandò loro di
proclamare la “professione di fede” del concilio di Nicea. Nacque un tumulto
per le intimidazioni del vescovo Valente. Il concilio fu interrotto e proseguì
nel palazzo imperiale. Rimasero solo tre vescovi a difesa dell’ortodossia:
Dionigi di Milano, Lucifero di Cagliari ed Eusebio di Vercelli, che dovettero
prendere la via dell’esilio.
La professione di fede sottoscritta a Nicea nel 325 era stata messa da
parte, proprio perché imposta con fermezza da Costantino, da quei padri
conciliari che non l’avevano digerita e da altri che, pur avendola difesa,
preferivano vivere in pace. Il vescovo di Roma, sotto l’impulso di Atanasio,
aveva contribuito a rilanciarla come base dell’approfondimento della
teologia trinitaria. Eusebio la ripropone nella fase più acuta della
controversia. La sua presa di posizione infondeva coraggio a Lucifero e a
Dionigi, scatenando la reazione degli Ariani. Costanzo non esita a spedire in
esilio i tre vescovi dissenzienti. Qualche tempo dopo fu mandato in esilio
anche papa Liberio. L’acquiescenza della maggioranza dei vescovi al volere
dell’imperatore contribuiva a introdurre la dottrina eterodossa in Occidente.
Eusebio fu esiliato a Scitopoli in Palestina, Lucifero a Germanica in Siria e
Dionigi in Armenia. Il fatto nuovo era la separazione degli esiliati.
-
21
La città di Scitopoli accolse Eusebio nella casa-‐‑prigione preparata per
lui dal vescovo Patrofilo, presente a Nicea e poi passato agli Ariani.
Scitopoli affonda le sue origini nella storia più antica. Per la sua
posizione strategica sulla “via del mare”, la città fu conquistata dal faraone
Tutmosi III nel 1489 a.C. e dopo qualche anno riconquistata dai Cananei.
Durante l’epoca ellenistica la città assunse il nome di Scitopoli. Cadde poi
sotto i Seleucidi di Tolomeo e durante la rivolta dei Maccabei fu occupata da
Giovanni Ircano; tornò agli Ebrei nel 107 a.C., finché fu conquistata da
Pompeo nel 63 ed entrò nella federazione della Decapoli.
Il cristianesimo giunse presto a Scitopoli. Al tempo del Concilio di
Nicea era divenuta “diocesi” e il suo vescovo era Patrofilo. Non lontana era
Cesarea, dove Origene aveva lasciato la sua grande biblioteca. Eusebio ora
rimeditava la storia biblica e cristiana in quel luogo di persecuzione e così
fortificava il suo spirito. A Scitopoli riceveva talvolta le visite dei suoi
presbiteri e dei fedeli di Vercelli. Ai poveri del territorio distribuiva i beni che
gli offrivano gli amici e dispensava anche la parola di Dio secondo le verità
della Chiesa, motivo per cui fu trasferito prima in Cappadocia e infine nel
deserto egiziano della Tebaide. Laggiù si ritrovò vicino a Lucifero di Cagliari.
2.2 Dimensione monastica
Nella Tebaide respirò il clima esaltante del monachesimo egiziano. Dall’esilio
riuscì ad inviare una lettera in cui manifesta tutta la sua umanità e la sua
paternità. La sua preoccupazione era che i suoi fratelli perdessero la fede
lasciandosi trascinare al credo degli Ariani. Fu grande il suo conforto nel
sapere che tutti erano rimasti fedeli. La violenza fisica e psicologica che
Eusebio subì si evince dalle tante lettere che i messaggeri avevano recato con
sé. Eusebio decise, allora, di fare lo sciopero della fame e lo comunicò per
lettera al suo vescovo carceriere. Le parole con le quali Eusebio comunica ai
suoi carcerieri la decisione di astenersi dal cibo fino a lasciarsi morire si
-
22
trasfigurano fino a divenire una “professione di fede” ed una
“evangelizzazione”. Eusebio al quarto giorno fu ricondotto con gli altri
esiliati alla prima dimora. Ma poiché il favore del popolo cresceva, dopo
alcuni giorni ripresero con più violenza le persecuzioni, la tortura,
l’isolamento e persino il tentativo di uccidere il santo vescovo. Eusebio
afferma che a causa della ferocia dei suoi carcerieri sono crollati molti fedeli
ed alcuni vescovi hanno abbandonato la verità. Allude poi ad altri
maltrattamenti. Il Vescovo di Vercelli conclude la sua lettera dicendo che egli
non si lascia spaventare dalle azioni degli Ariani e raccomanda ai suoi
presbiteri e al popolo la fedeltà alla verità.
Un’altra fonte storica è il testo di Epifanio, vescovo di Salamina. Egli
narra di aver visitato la città di Scitopoli e di aver conosciuto Giuseppe, il
ricco giudeo cristiano nella cui casa aveva abitato Eusebio durante l’esilio.
Godendo di una certa libertà di movimento, forse Eusebio l’aveva utilizzato
per avvicinare la gente ed evangelizzarla, scatenando così la reazione dei
suoi custodi, guidati da Patrofilo. La scelta dell’imperatore, indovinata nella
sua iniquità, si pensa sia stata suggerita dai focosi ariani Valente e Ursacio,
convinti che il vescovo di Scitopoli Patrofilo potesse essere il carceriere più
adatto. Patrofilo pensava di ridurre Eusebio al totale silenzio. Forse non
immaginava che Eusebio sarebbe riuscito a sfuggire comunque alla morsa
della prigione per infondere a molti fedeli l’antidoto della vera dottrina. Fu
giocoforza trasferirlo in Cappadocia, ma, dal momento che il secondo esilio
risultò rischioso agli occhi dei nemici, egli fu tradotto definitivamente nella
lontanissima e desertica Tebaide. Nella stessa regione approdò Lucifero. Si
ritrovarono nello stesso territorio dell’Alto Egitto i tre grandi difensori del
Credo niceno: Eusebio, Lucifero e Atanasio. I tre teologi riuscirono
probabilmente a mettersi in comunicazione fra loro per ravvivare in esilio la
loro convinzione teologica e il loro zelo apostolico.
La morte improvvisa di Costanzo il 3 novembre del 361 proietta sul
-
23
trono imperiale suo cugino Giuliano, poi chiamato “l’apostata”. Fu lui a
restituire la libertà a tutti gli ecclesiastici esiliati da Costanzo. Era stato
“lettore” nella Chiesa, ma, divenuto imperatore, pensò di combattere la
Chiesa che Costanzo a suo modo aveva protetto. Agli inizi del 362 diede la
libertà a Eusebio e Lucifero, che poterono tornare alla piena attività di
evangelizzazione. Eusebio e Lucifero furono raggiunti dall’invito di Atanasio
a partecipare ad un concilio convocato ad Alessandria. Lucifero di Cagliari
invia al concilio due diaconi suoi delegati e si reca personalmente ad
Antiochia per influire sulle vicende di quella Chiesa. Qui Melezio, deposto
ed esiliato da Costanzo, dovette affrontare l’ostilità del prete Paolino;
Lucifero sostenne Paolino e lo ordinò vescovo contrapponendolo a Melezio e
trasformando la controversia in un autentico “scisma”32.
La “Lettera Sinodale” inviata dai Padri Conciliari alla Chiesa di
Antiochia, chiamata Tomus ad Antiochenos, di cui si riporta il testo
nell’Appendice, informa sullo svolgimento del “Concilio dei Confessori”.
Il messaggio fu indirizzato anche ai vescovi d’Italia, Egitto, Libia e
Arabia presenti al Concilio, tra i quali era Eusebio, unico vescovo
d’Occidente. Nel Tomus gli Alessandrini mostravano simpatia per il niceno
Paolino di Antiochia. Si aggiungeva la questione della cristologia di
Apollinare di Laodicea. La simpatia di Apollinare verso Paolino di Antiochia
rappresentò un nuovo punto di disaccordo con gli avversari. Atanasio
propose al Concilio una formula cristologica ambigua e sfumata, così da
poter essere sottoscritta da tutti. Su questo punto Eusebio prese le distanze
dal vescovo di Alessandria, contrapponendo alla debole definizione
atanasiana di “corpo di Cristo” la chiara affermazione che “il Figlio di Dio è
diventato uomo avendo assunto tutto dell’uomo all’infuori del peccato, quale
32 Cfr G. F. DIERCKS, Luciferi Calaritani opera quae supersunt, CCL VIII, Turnholti 1978; per una bibliografia completa cfr A. PIRAS, Luciferi Calaritani de non conveniendo cum haereticis, Roma 1992.
-
24
era stato il nostro vecchio uomo”33. Eusebio rivolse agli Antiocheni un invito
alla concordia e tornò in Occidente. Dopo sette anni di esilio e rinvigorito
nella sua scienza teologica, si sentiva investito di una missione universale per
la rinascita della verità cristologica e trinitaria. Per far ritorno in patria, scelse
la via terrestre e fluviale per trasmettere alle comunità incontrate lungo il
viaggio il verbo niceno. Si ferma soprattutto nella città di Sirmio nella
speranza di guadagnare alla sua causa il vescovo Germinio. Di questi fatti ci
informa il testo della Altercatio Heracliani laici cum Germinio episcopo Sirmiensi,
che contiene il resoconto della disputa di Germinio con Eracliano del 366.
Pochi anni dopo, il vescovo di Sirmio si staccò dagli irriducibili ariani
Ursacio e Valente e sottoscrisse una formula di fede più vicina al Credo di
Nicea. Eusebio tornò alla sua Vercelli con il proposito di potenziare la vita
monastica nel clero e nel popolo, coadiuvato dal presbitero greco Limenio e
dal siriaco Evagrio. A lui affidò la traduzione in latino della Vita di Antonio.
Sulla scia di Eusebio, qualche anno più tardi istituiranno la vita monastica
per il clero anche Martino in Gallia e Agostino in Africa. Il vescovo di
Vercelli contribuì a fondare le nuove diocesi di Novara, Tortona e Ivrea.
Ci fornisce una conferma dell’azione evangelizzatrice di Eusebio ed
Ilario la notizia secondo cui questi erano presenti nell’anno 364 a Milano a
combattere l’ariano Aussenzio per riconquistare Milano e per sottrarre l’Italia
e l’Occidente all’Arianesimo. I due vescovi andarono nella città per
propagandare tra i fedeli la dottrina nicena. All’imperatore domandarono la
deposizione di Aussenzio in quanto eretico, e questi replicò all’imperatore
che anche Ilario era stato radiato dalla sua diocesi. Ilario è la fonte di questa
notizia e possiamo pensare che Aussenzio abbia rivolto una simile accusa
anche ad Eusebio. I due teologi furono messi alla porta dall’imperatore
Valentiniano, succeduto nella guida dell’impero a Giuliano l’Apostata.
Valentiniano, per ragioni prevalentemente di ordine pubblico, dava ragione 33 Sul Concilio di Alessandria si veda SIMONETTI, La crisi ariana cit., 258 ss.
-
25
ad Aussenzio, lasciandolo nella sede di Milano. Aussenzio, infatti, aveva
negato di essere ariano giurando di seguire la vera fede.
Nel breve arco di dieci anni, dal 355 al 364, si svolse e si esaurì la
parabola dell’attività di Eusebio in difesa della fede nicena contro gli Ariani.
Da quanto sappiamo di lui, egli occupa sempre una posizione di rilievo.
L’esigua produzione letteraria che di lui ci è rimasta ci impedisce di
conoscerlo più a fondo, soprattutto per quanto riguarda la sua
interpretazione della fede nicena. Di lui in antico era nota solo la traduzione
del Commento ai Salmi di Eusebio di Cesarea; il che fa intendere che egli non
ritenne opportuno corredare alla sua azione antiariana un’omologa attività
letteraria. Indubbiamente Eusebio fu in grado di ripensare autonomamente e
in profondità i dati dottrinali della controversia. La chiarezza della sua
professione di fede fu la ragione dell’efficacia della sua azione politica. Il
prestigio di cui Eusebio di Vercelli fu circonfuso fin dal suo primo apparire
alla ribalta della storia appare pienamente giustificato34.
34 Cfr. M. SIMONETTI, Eusebio nella controversia ariana, in Eusebio di Vercelli e il suo tempo cit., 155-‐‑179.
-
26
CAP. 3
Eusebio al Concilio di Alessandria
3.1 Il contributo di Eusebio di Vercelli al Concilio di Alessandria (362)
Al concilio di Alessandria del 362 fu protagonista Eusebio insieme con
Atanasio. Nonostante siano scarsi i dati biografici di Eusebio, quell’evento è
uno dei meglio documentati ed appare come uno dei più significativi e
decisivi della sua vita.
Eusebio vive in un’epoca della storia della Chiesa in cui il fenomeno
conciliare conosce un’accelerazione senza precedenti, soprattutto a causa
delle controversie connesse con l’arianesimo. Fra il 320 ed il 382 si contano
circa 118 concili celebrati, contro una novantina dei due secoli e mezzo
precedenti. Il concilio alessandrino del 362, passato alla storia come il
“concilio dei confessori”, rappresentò anche l’inizio di una vera e propria
svolta teologica ed ecclesiale. Cercheremo ora di analizzare meglio le
dinamiche di questo concilio nel contesto delle controversie teologiche del
sec. IV, con particolare riguardo ai contributi di Atanasio e di Eusebio di
Vercelli alla questione trinitaria, alla cristologia, alla mariologia, e agli altri
ambiti da lui toccati.
Il concilio di Alessandria del 362 venne a trovarsi all’inizio della
discesa nella parabola storica dell’arianesimo35. La controversia tra Ario ed il
suo vescovo Alessandro fu originariamente una polemica interna
all’origenismo. Tuttavia, il problema investì presto la totalità del mondo
cristiano orientale e, di riflesso, anche occidentale. Purtroppo, la formula di
Nicea risultò come imposta dall’alto e con troppa fretta per riuscire a
convincere tutti. Il dialogo e l’approfondimento teologici dovettero così farsi
35 Cfr. SIMONETTI, La crisi ariana cit., 359-‐‑370.
-
27
strada attraverso l’esplosione di contese e scismi, aggravati e incancreniti da
interessi palesi e occulti non propriamente teologici. Dieci anni dopo Nicea,
questo intrico si manifestò nei concili di Tiro e Gerusalemme.
La morte di Costantino (22 maggio del 337) e le vicende tragiche della
sua successione complicarono ulteriormente le cose anche in campo
religioso. Il caso di Atanasio e di altri vescovi contestati dai filoariani guidati
da Eusebio di Nicomedia venne affrontato al concilio di Roma del 341 e la
decisione fu a favore di Atanasio. La risposta arrivò dal “Sinodo della
dedicazione” tenuto ad Antiochia e accompagnato da quattro simboli di fede
che non contenevano l’homousion, ma che non erano neppure ariani. È
l’inizio di tutta una serie di simboli che si succederanno nei decenni
seguenti, basati su un complesso di equivoci e di travisamenti delle posizioni
altrui. L’aspetto più importante era la mancanza di vera comunicazione fra
le parti. La prima occasione di incontrarsi sarebbe potuto essere il concilio di
Roma del 341 sollecitato dagli avversari di Atanasio e da loro poi disertato.
L’altra opportunità sarebbe potuta essere Serdica nel 343, e invece si ebbe la
prima formale rottura fra le Chiese di Oriente e Occidente. I concili e i
simboli di fede dal 343 al 356 manifestarono soltanto tendenze opposte e
timori reciproci.
In questa atmosfera l’homousios niceno risultò quasi totalmente
dimenticato. A questo punto emersero anche le incertezze e i contrasti
interni del fronte formatosi contro quel medesimo homousios niceno e si
manifestarono formalmente i “partiti dell’arianesimo”: “anomei”, “omei”,
“omeisti” e “omeousiani”. Gli occidentali presero l’iniziativa di riflettere
nuovamente sull’ homousios niceno: dapprima papa Liberio nel 354, con una
lettera all’imperatore Costanzo, poi Eusebio di Vercelli nel 355 nel concilio
radunato a Milano, che però si concluse con l’esilio per sé, per Lucifero di
Cagliari e Dionigi di Milano. Nel concilio degli occidentali a Rimini e in
quello degli orientali a Seleucia, tenutisi entrambi nel 360, la formula omea
-
28
poté essere imposta da Costanzo II; per reazione, la formula nicena riprese
forza e attualità.
Trentacinque anni di controversie avevano ormai dimostrato che l’
homousios restava un punto di riferimento inevitabile e tanto più cresceva
quanto più lo si negava. La politica religiosa di Costanzo II fu perciò un
fallimento. Altrettanto quella filopagana dell’imperatore Giuliano. I primi ad
approfittare della nuova situazione, muovendosi nel senso anzidetto, furono
i cristiani della Gallia. Nel corso dei mesi successivi si celebrarono vari
concili che ribadirono la validità dell’ homousios niceno e assunsero un
atteggiamento di intransigenza nei confronti dei capi ariani, favorendo
peraltro una miglior comprensione dei termini del problema dottrinale.
Omousiani e omeousiani cominciarono a cercarsi e a dialogare. In questa
nuova atmosfera operò anche il concilio di Alessandria del 362.
3.2 Redazione del Tomo agli Antiocheni e contributo di Eusebio alla
questione trinitaria, alla cristologia e alla mariologia
Nel febbraio del 362, Atanasio di Alessandria tornò nella propria città dal
suo terzo esilio. Giuliano dal febbraio del 361 aveva emanato il decreto sulla
liberazione degli esiliati; Costanzo II era morto il 3 novembre successivo e
nel dicembre il nuovo imperatore, dichiaratamente pagano, era entrato a
Costantinopoli. Bisognava affrontare il problema del paganesimo tornato
sulla breccia e quello dell’unificazione delle forze cristiane ortodosse.
Atanasio nella primavera del 362, con un gruppo di vescovi rientrati come
lui dall’esilio, radunò un concilio. Benché i membri dell’assemblea fossero
perlopiù egiziani, erano presenti anche l’italiano Eusebio di Vercelli e l’arabo
Asterio di Petra. Vi erano inoltre i rappresentanti di Lucifero di Cagliari, di
Apollinare di Laodicea e di Paolino, il prete a capo delle comunità cristiane
esistenti ad Antiochia. La discussione si concluse con la redazione di un
-
29
Tomo36, cioè di una lettera destinata ai gruppi cristiani di Antiochia, ma
indirizzata a Eusebio e Asterio, i due vescovi delegati, e a Lucifero, Cimazio
e Anatolio, i tre vescovi che erano già ad Antiochia. Il documento è
considerato opera di Atanasio, anche se esprime il pensiero dell’assemblea.
Nel Tomo si trova l’esortazione a ricostruire l’unità e la concordia attorno
all’essenziale, ossia quanto stabilito a Nicea. Anche ad Alessandria prevalse
il criterio della moderazione nel trattamento da riservare ai vescovi non
troppo compromessi con l’arianesimo.
Emerge nel Tomo un accenno alla problematica riguardante lo Spirito Santo,
in rapporto alle prime affermazioni dei “pneumatomachi”, detti poi
“macedoniani”. Nel documento si rileva una singolare inchiesta dottrinale
tra omeusiani (o omoiusiani) e pseudosabelliani; si conclude dicendo che
entrambi sono ortodossi se concordi nel dire che la fede confessata dai Padri
a Nicea è migliore e più esatta e se in seguito si useranno i termini di quella
professione. Il problema trinitario è così risolto mettendo da parte la
terminologia discussa e tornando all’ homousios. Un’analoga prospettiva si
delinea nella questione cristologica, di cui si colgono le prime avvisaglie
dell’apollinarismo. Il problema venne aggirato con formulazioni generiche
accettabili da tutti. Il motivo di fondo è costituito dal fatto che non si sarebbe
dovuta fare alcuna indagine al di là del concilio di Nicea, né si sarebbero
dovute tollerare parole derivanti dallo spirito di contesa. Il Tomo agli
Antiocheni per ottenere la conciliazione fu restio ad approfondimenti
dottrinali, che pur vennero da altre parti. Tuttavia, il documento ebbe il
merito di porre sul tappeto il problema trinitario nella sua globalità,
accennando anche allo Spirito Santo, e il problema cristologico, rilevandone
la complessità.
Eusebio di Vercelli dovette contribuire in maniera non secondaria alla
celebrazione del concilio e alla redazione del documento, il quale alla fine 36 Cfr. E. BELLINI, Su Cristo: il grande dibattito nel quarto secolo, Milano 1978, 489-‐‑494.
-
30
riporta in greco: “Eusebio ha sottoscritto questo documento in romano (scil.
latino)”. È interessante confrontare questo piccolo contributo di Eusebio con
un’altra sua dichiarazione di fede che è contenuta nel libello di protesta a
Patrofilo e inclusa nella seconda delle due lettere sicuramente autentiche,
inviate al clero e al popolo della propria diocesi durante l’esilio, fra il 355 e il
360. Da quanto egli scrive nel libello si rileva che al concilio di Alessandria la
riflessione sul Padre e il Figlio viene completata dalla dichiarazione di
accordo circa le ipostasi; la dottrina dell’incarnazione e della redenzione è
approfondita dal riconoscimento che il Figlio di Dio, oltre ad essere divenuto
anche figlio dell’uomo, ha anche preso, eccetto il peccato, tutto ciò che
costituisce il nostro antico uomo, tale e quale. Infine, la proclamazione della
fede della Chiesa cattolica è precisata escludendo il “documento di Serdica”,
affinché non si proponga nulla che sia al di là della fede di Nicea. Eusebio di
Vercelli dimostrò la pro